Protocollo Liberi di scegliere
"Liberi di scegliere" è un protocollo d'intesa interministeriale nato da una prassi giudiziaria avviata nel 2012 presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, oggi attivo in tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è «assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, o che siano vittime della violenza mafiosa, e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali»[1]
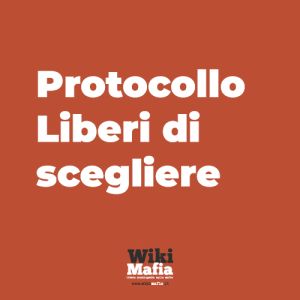
Storia
Le origini calabresi di Liberi di scegliere
La necessità di un nuovo corso da parte del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nacque per via degli elevati procedimenti penali di cui si era dovuto occupare nel corso degli anni, come raccontato nel 2015 dal giudice Roberto Di Bella, divenuto poi Presidente del medesimo Tribunale, oggi a capo di quello per minorenni di Catania:
«Negli ultimi venti anni il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha trattato più di cento procedimenti per reati di criminalità organizzata e connessi e oltre cinquanta processi per omicidio/tentato omicidio nei confronti di minori, molti dei quali - ormai maggiorenni - sono sottoposti al regime carcerario dell'art. 41-bis Ord. pen., sono stati uccisi nel corso di faide familiari o hanno la leadership nella 'ndrina di appartenenza»[2]
Da qui l'idea di una nuova prassi giudiziaria che si muovesse all'interno di una cornice educativa in cui il privato sociale e le agenzie del territorio collaborassero con l’istituzione pubblica attraverso l’attivazione di equipe specializzate nel fornire quel supporto psicologico e sociale necessari per vivere un'esistenza sganciata dalle dinamiche criminali[3].
L'indottrinamento mafioso nelle 'ndrine
La struttura della 'ndrangheta fa sì che il perimetro dell'organizzazione criminale coincida con quello della famiglia di sangue. In tale contesto, il legame affettivo viene sfruttato per creare un sodalizio criminale impenetrabile: «pentirsi significa tradire i propri congiunti e questo comporta problemi di ordine morale e psicologico assai più pesanti della paura di vendette e ritorsioni»[4].
L'educazione familiare in una 'ndrina, sin dalla tenera età della prole, è improntata a garantire quel ricambio generazionale necessario alla sopravvivenza dell'organizzazione criminale nel tempo. L'affettività e il codice familiare consentono una trasmissione tanto efficace del codice mafioso da permettere a questo di essere introiettato ad un livello più profondo della psiche umana. Il risultato è che non si trasmette solo una mentalità (cd. pensare mafioso), ma si plasma la componente più ancestrale, affettivo-emozionale, di ciascun individuo (cd. sentire mafioso)[5].
Un esempio su tutti della black pedagogy[6] condotta dalla 'ndrangheta si ha nella «Ninna nanna du malandrineddu»: si tratta di una ninna nanna «che una mamma canta al proprio bimbo, raccomandandogli di crescere in fretta per impugnare un pugnale e vendicare il padre. Ecco questi sono i valori della 'ndrangheta: sangue, violenza, morte; questi sono i valori che una donna di 'ndrangheta trasmette ai propri figli»[7].
Il pensare mafioso
Il pensare mafioso, o cultura di mafia, è il bagaglio culturale che caratterizza trasversalmente qualsiasi sistema-mafia; e che è destinato poi a declinarsi secondo le tipicità che caratterizzano ciascuna organizzazione criminale di stampo mafioso.
Se scopo primario di tutte le organizzazioni mafiose è garantire la continuità del proprio potere, la cultura di mafia necessita di costruire l'organizzazione criminale come una super-entità in grado di imporsi sulle singole individualità al suo interno, asservendole completamente a tale scopo.
Il singolo membro, dunque, non è considerato come un soggetto che ha valore in sé e per sé in quanto persona, ma ne diviene degno solo in quanto ingranaggio che apporta utilità nell'interesse esclusivo dell'organizzazione. Del resto, la nota definizione "uomo d'onore" è emblematica di una simile concezione, che esaurisce la dignità della persona nel suo essere assoggettata, in modo totalizzante, all'organizzazione di riferimento[8].
Nel pensare mafioso non c'è spazio per l'Identità, ma solo per l'identicità; non per il pensiero autonomo, ma per il non-pensiero e per l'omertà[9]. L'omertà «non consiste solo in un patto sul silenzio, ma anche nel non avere niente da dire, inteso come non avere più niente da pensare, poiché tutto è già pensato, già pre-scritto da un codice familiare culturale che esaurisce ogni possibile significazione, che dà per scontato tutto ciò che accade»[10].
Anche per questo motivo, non sono mancati negli anni degli accostamenti tra cultura di mafia e fondamentalismo, dove il tratto fondamentalista causa un malfunzionamento nell'attività psichica dell'individuo (cd. psicopatologia)[11].
Laddove la famiglia criminale coincide con la famiglia biologica, come tipicamente accade nella 'ndrangheta, il suddetto processo di «nientificazione»[12] delle singole personalità viene perpetrato direttamente dai riferimenti familiari e dai legami parentali.
La famiglia dovrebbe essere il naturale «luogo di mediazione interazionale tra l'individuo - suo membro - e la società»[13], cioè dovrebbe essere funzionale a una corretta promozione e responsabilizzazione dei suoi membri verso l'età adulta.
La famiglia di 'ndrangheta, al contrario, diviene spesso il contesto in cui i bambini vengono educati sin da piccoli a non avere alcuno spazio di autonomia e di scelta sulle proprie vite[14]. «Lavorando per trasformare l'affetto in fedeltà»[15] incondizionata e costruendo, così, l'identità del figlio in modo da impedirgli di potersi concepire come "altro" rispetto all'organizzazione.
La contiguità alla mentalità mafiosa
La cultura di mafia non viene subìta solamente da chi sta all'interno dell'organizzazione criminale, ma anche da tutta una serie di soggetti, specie minorenni, che vivono ai margini della stessa e della società. In particolare, essa esercita un forte potere attrattivo in aree geografiche caratterizzate da deprivazione sociale e povertà culturale; a fronte, invece, di un'alta presenza mafiosa[16].
In questo “humus” i sistemi di criminalità organizzata diventano punto di riferimento per giovani e giovanissimi. Nella crisi della scuola, della famiglia e delle altre strutture sociali, le mafie sembrano spesso l’unico soggetto che riesce a dare un’identità e una parvenza di integrazione a ragazzi che hanno davanti a sé soltanto la miseria economica e culturale dei nuclei di provenienza e la disattenzione delle istituzioni. Bisogna però osservare che ciò che dà risposta ai loro bisogni è la cultura di mafia, prima ancora che il sistema criminale mafioso.
L’onore, il rispetto e la dignità individuale sono questi i valori che caratterizzano i sistemi di mafia e che ne definiscono la cultura. Un bagaglio che spesso trae fonte di ispirazione proprio nella cultura popolare; solidarietà, centralità della famiglia e religiosità, sebbene siano valori solo “dichiarati” e non realmente vissuti, sono usati con la finalità di acquisire consenso e coprire una realtà violenta e prevaricatoria, intrisa di sessismo, razzismo e xenofobia[17].
L'educazione nella famiglia di 'ndrangheta, nel racconto di Emilio Di Giovine
Nel racconto di Emilio Di Giovine, esponente apicale della 'ndrina dei Serraino-Di Giovine di Reggio Calabria, oggi collaboratore di giustizia, è emerso come sin da giovanissimo fosse stato educato a vedere la violenza come "normale" nei rapporti con gli altri[18]:
«A otto, dieci anni, già ho avuto le armi in mano, praticamente nascondevo anche le pistole. […] Ero un picciottino quando mio nonno, per renderci più “masculi”, costringeva me e i miei cugini a mangiare il peperoncino direttamente dalla pianta. I miei occhi piangevano, ma dovevo resistere per dimostrare di essere uomo. Mi faceva anche girare il sangue del porco, a Natale. Avrò avuto quattro anni, al massimo cinque. […] Erano prove di virilità per formare noi bambini e diventare uomini d’onore. […]
Un giorno, un fratello di mia madre, sapendo che avevo assistito alla contesa tra due cugini, mi chiese chi è che aveva iniziato per primo. […] Io stavo zitto, ma lui continuava, insisteva: “Dimmelo, tanto non ti fazzu nenti”. A un certo punto mi fidai e cedetti. Ma non era altro che una trappola per mettermi alla prova. Appena glielo dissi, mi punì con un manrovescio così forte che mi fece girare la testa per mezz’ora. […]
Alla violenza seguiva la spiegazione: “Vedi Emiliuzzeddinu, non è che ti ho dato lo schiaffo perché ti volevo male, ma tu ti ricorderai sempre nella vita che prima di dire qualcosa a qualcuno, specialmente alla polizia, ci pensi un bel po’. Non lo dirai mai, anche se ti dicono che è così, non è mai così”. […]
Te lo inculcano da giovane. La morte precoce diventa possibile anche per te. E allora l’accetti e diventi fatalista. Sviluppi per forza un atteggiamento distaccato, lontano. Prima mi sentivo un superuomo. È così che ti fanno diventare. […] Ti dicono che i contrasti (cioè le persone non affiliate) sono dei fessi, che i soldi sono importanti, che gli sbirri sono da disprezzare.
La ‘ndrangheta è dura, schifosa. Ma ti crescono facendotela sembrare l’unico mondo possibile. […] Allora per me la violenza mafiosa era normale, naturale. E la consideravo necessaria per quello che volevamo raggiungere, per gli equilibri tra le famiglie. Ti indottrinano, ti temprano come gli adepti. La ‘ndrangheta ti tiene legato a sé. Anche se non sei affiliato. È dura separarsi, staccarsi. La famiglia, allargata, ti dà un senso di protezione unico difficilmente trovabile all’esterno».
Il progetto Liberi di scegliere
I provvedimenti de potestate e l'allontanamento del minore dalla Calabria
A partire dal 2012, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha assunto provvedimenti di decadenza o di sospensione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 Cod. civ.) nei confronti di genitori, o di altri esercenti tale responsabilità, che abbiano perpetrato modelli educativi conformi alla cultura di mafia e tali da essersi tradotti in un serio pregiudizio per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori a carico[19].
A tali provvedimenti si è accompagnato, qualora necessario, l'allontanamento del minore dal contesto d'origine ex artt. 25 e 26 R.D.L. 1404/1934, disponendone la collocazione fuori dalla regione Calabria per un periodo limitato di tempo; e comunque non oltre il compimento della maggiore età[20]. Si tratta comunque di misure sempre modificabili o revocabili ex art. 742 Cod. proc. civ., la cui adozione viene sempre valutata caso per caso, senza ricorrere ad automatismi.
Scopo dell'allontanamento e dell'inserimento in altro contesto familiare e socio-culturale è quello di salvaguardare la personalità minorile, fornendo quelle «opportunità di crescita e di realizzazione personale»[21] giudicate impossibili nell'ambiente d'origine.
Come ricordò il giudice Di Bella:
«Non si trattava di rieducare nessuno. Semplicemente di mostrare a questi ragazzi che fuori dagli spazi chiusi delle loro case esisteva un altro mondo. Non avremmo mai chiesto loro di rinnegare i padri e le madri. Solo di domandarsi se veramente volevano per il loro futuro la strada che le famiglie avevano scelto per loro. Se se la sentivano di costruire una vita che dovesse sopportare ogni giorno il peso delle perquisizioni, del carcere, della violenza, o se intendevano provare a costruire qualcos’altro»[22].
La mission istituzionale: agire nell'interesse del minore, supplendo alle carenze familiari
Secondo il Codice civile italiano, l'educazione è sia un diritto del figlio (art. 315-bis), sia un diritto e un dovere del genitore (art. 147). In particolare, il minore ha diritto a essere educato dalla propria famiglia (comma II, art. 315-bis). Il diritto all'educazione va esercitato, tuttavia, «nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni» del figlio stesso.
Questo limite rende funzionale il diritto all'educazione al soddisfacimento di quello che viene definito, anche a livello sovranazionale[23], "superiore interesse del minore", indicandone la posizione di «preminenza»[24] rispetto a eventuali altri interessi in gioco.
In un assetto istituzionale come quello italiano, la libertà educativa della famiglia è garantita solo fintanto che questa non si spinga al punto di rinnegare questo interesse superiore. Qualora quest'ultimo dovesse essere minacciato dall'educazione familiare, il Legislatore italiano ha previsto un intervento esterno in funzione suppletiva da parte delle Autorità competenti a garantire la salvaguardia del benessere minorile, quale ad esempio il Tribunale per i minorenni[25].
La riforma della normativa in tema di rapporto di filiazione, approvata col Decreto legislativo n. 154/2013, ha sostituito, in tutti i testi di legge, la locuzione "potestà genitoriale" con quella di "responsabilità genitoriale". La modifica non è solamente terminologica, ma riflette l'intento di rinnovamento sottostante: parlare di «genitorialità responsabile»[26], anziché di genitorialità potestativa, posiziona il figlio al centro del rapporto con il genitore e permette il passaggio dalla concezione «il figlio è mio» a quella «ho il dovere di cura di mio figlio»[27].
La posizione del Consiglio Superiore della Magistratura
A seguito dei risultati raggiunti dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il Consiglio Superiore della Magistratura nel 2017, dopo aver definito le famiglie mafiose come «maltrattanti, abusanti dei loro figli»[28], approvò la prassi giudiziaria avviata dal Tribunale, definendola «una delle più avanzate modalità di tutela del minore nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata»[29].
I Protocolli d'intesa Liberi di scegliere e la Proposta di Legge alla Camera, n. 2072/2019
Inizialmente, Liberi di scegliere è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Tribunale per i minorenni, i Servizi minorili di amministrazione della giustizia e realtà del Terzo settore. In particolare, alcune associazioni antimafia come AddioPizzo e Libera contro le Mafie hanno permesso di garantire il supporto operativo necessario all'accoglienza nelle località di destinazione, per via delle numerose forze legate al loro attivismo sociale, nonché della loro diffusione territoriale.
Nel 2017, gli Stati Generali della Lotta alle Mafie hanno posto in luce la necessità di «individuare un modello, giuridico, organizzativo e sociale realmente efficace, che affronti in un’ottica di sistema il fenomeno del coinvolgimento dei minori nelle associazioni criminali e della suggestione esercitata da determinati modelli culturali nelle variegate realtà territoriali»[30].
Col passare del tempo, la pratica andata a buon fine con i primi casi di minorenni allontanati dalla Calabria è stata trasferita in una serie di Protocolli d'intesa, che hanno visto nuovi partner istituzionali e para-istituzionali affiancarsi all'attività giudiziaria minorile svolta a tutela dei cd. minori di mafia. Tra le tante intese siglate, sia su scala nazionale, sia a cascata a livello locale, fu fondamentale il Protocollo del 5 novembre 2019, poi rinnovato il 31 luglio 2020 con la previsione di un'importante novità: qualsiasi Tribunale per i minorenni d'Italia può oggi adottare le misure sopracitate a favore di minori pregiudicati dalla subcultura mafiosa, disponendone l'inserimento nel progetto Liberi di scegliere.
L'8 agosto 2019 è stata depositata alla Camera dei deputati la Proposta di Legge n. 2072, contenente una serie di inviti alla «modifica del Codice civile e del Codice di procedura penale, nonché altre disposizioni, per la protezione e l'assistenza dei minorenni in condizioni di rischio fisico e psicologico appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendono dissociarsi da tali contesti»[31].
Il coinvolgimento dei familiari del minore e la "terza via"
Liberi di scegliere è stato esteso anche ai familiari che hanno espressamente chiesto di essere aiutati a fuggire per ricostruirsi una vita altrove, lontano dal peso opprimente della subcultura mafiosa. Alcuni di loro intraprendono un percorso di collaborazione con la giustizia, altri divengono testimoni di giustizia, altri ancora chiedono semplicemente di poter seguire i loro figli per vivere secondo legalità.
Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera contro le Mafie, associazione tutt'oggi partner fondamentale del Progetto, ha fatto riferimento a quest'ultima categoria di soggetti adulti, soprattutto donne e madri, parlando di un nuovo scenario e definendolo "terza via", rispetto alle strade già possibili, nell'ordinamento italiano, per coloro che intendono sottrarsi al contesto malavitoso di provenienza: diventare collaboratori o testimoni di giustizia, come si è detto, e quindi fornire informazioni utili allo Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Auspicando un rinnovamento della legislazione vigente, Don Luigi Ciotti riflette dunque sull'opportunità di estendere le già note garanzie di protezione e di reinserimento sociale in altro contesto geografico anche a chi ha manifestato la chiara volontà di rottura e di discostamento radicale dal mondo valoriale mafioso, scegliendo di iniziare una nuova vita per sé e per i propri figli[32].
Note
- ↑ Citato in Protocollo d'intesa Liberi di scegliere, 5 novembre 2019[1]
- ↑ Estratto dell'intervento dell'allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria dott. Roberto Di Bella al Convegno "Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L'orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria", tenutosi a Roma, presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama, il 24 novembre 2015. Citato in Michele Filippelli (2017). Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale, Milano, Diritto Avanzato, p. 30.
- ↑ Citato in Roberto Di Bella, Monica Zapelli (2019). Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta, Milano, Rizzoli, p. 93.
- ↑ Citato in Nicola Gratteri, Antonio Nicaso (2019). Fratelli di sangue, Cosenza, Mondadori, p. 8.
- ↑ Franco Di Maria (1998). Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni, in La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo, Milano, FrancoAngeli, p. 39.
- ↑ Roberto Di Bella, Giuseppina Maria Patrizia Surace (2019). Il progetto Liberi di scegliere. La tutela dei minori di 'ndrangheta nella prassi giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, p. 9.
- ↑ Citato in Serena Uccello (2016). Generazione Rosarno, Milano, Melampo, p. 182.
- ↑ Ravelli Francesca (2022). La tutela civile del superiore interesse del minore. Analisi giuridico-sociologica sulla realtà di 'ndrangheta e sul ruolo della giustizia minorile, Roma, Aracne, pp. 81-112.
- ↑ Luisella Ferraris (1998). Mafia e psicopatologia. Spunti di riflessione tratti dai percorsi terapeutici di alcuni pazienti, in La mafia dentro, op. cit., pp. 157-178.
- ↑ Ivi, p. 177.
- ↑ Girolamo Lo Verso (1998). Mafia, psicopatologia, psicoterapia, in La mafia dentro, op. cit., pp. 129-156.
- ↑ Citato in Di Maria, op. cit., p. 45.
- ↑ Citato in Di Bella, Surace, op. cit., p. 13.
- ↑ Di Maria, op. cit., p. 38.
- ↑ Citato in Angela Iantosca (2015). Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta, Roma, Giulio Perrone Editore, p. 79.
- ↑ Ravelli, op. cit., pp. 81-87
- ↑ Citato in Stati Generali della Lotta alle Mafie, Lavori del Tavolo 10[2], Mafie e minori, 23 novembre 2017, pp. 185-189
- ↑ Iantosca, op. cit., pp. 63-66.
- ↑ Protocollo d'Intesa Liberi di scegliere, op. cit., p. 3.
- ↑ Roberto Di Bella (2016). Le potenzialità della giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo, in Minori e giustizia, 2016, n. 3, p. 18.
- ↑ Citato in Ibidem
- ↑ Citato in Di Bella, Zapelli, op. cit., p. 101.
- ↑ Vedasi art. 3, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989); art. 24, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000).
- ↑ Come citato in Corte cost., sentenza n. 11, 29 gennaio 1981, circa il fondamento costituzionale del concetto di "superiore interesse del minore" (vedasi, in particolare, i punti 4 e 6 del Considerato in diritto).
- ↑ Ravelli, op. cit., pp. 5-48
- ↑ Citato in Piercarlo Pazé (2007). Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale, in Minori e giustizia, 2007, n. 3, p. 8.
- ↑ Citato in Ibidem, p. 9.
- ↑ Citato in Risoluzione del CSM 31 ottobre 2017, La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata[3], p. 5.
- ↑ Ivi, p. 1.
- ↑ Citato in Stati Generali della Lotta alle Mafie, op. cit., p. 187.
- ↑ Citato in Proposta di Legge n. 2072, XVIII Legislatura, 8 agosto 2019[4].
- ↑ Luigi Ciotti, Contro i boss la terza via delle donne, 27/02/2024[5].
Bibliografia
- Di Bella, Roberto (2016). "Le potenzialità della giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo", in Minori e giustizia, 2016, n. 3.
- Di Bella, Roberto & Zapelli, Monica (2019). Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta, Milano, Rizzoli.
- Di Bella, Roberto & Surace, Giuseppina Maria Patrizia (2019). Il progetto Liberi di scegliere. La tutela dei minori di 'ndrangheta nella prassi giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino.
- Di Maria, Franco (1998). "Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni", in La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo, Milano, FrancoAngeli.
- Filippelli, Michele (2017). Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale, Milano, Diritto Avanzato.
- Gratteri, Nicola & Nicaso, Antonio (2019). Fratelli di sangue, Milano, Mondadori.
- Iantosca, Angela (2015). Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta, Roma, Giulio Perrone Editore.
- Lo Verso, Girolamo (a cura di) (1998). La mafia dentro, Milano, Franco Angeli.
- Pazé, Piercarlo (2007). "Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale", in Minori e giustizia, 2007, n. 3.
- Protocollo d'intesa Liberi di scegliere, 5 novembre 2019. (Testo del Rinnovo del 2024)
- Ravelli, Francesca (2022). La tutela civile del superiore interesse del minore. Analisi giuridico-sociologica sulla realtà di 'ndrangheta e sul ruolo della giustizia minorile, Roma, Aracne.
- Stati Generali della Lotta alle Mafie, Lavori del Tavolo 10, Mafie e minori, 23 novembre 2017.
- Uccello, Serena (2016). Generazione Rosarno, Milano, Melampo.